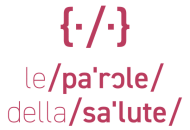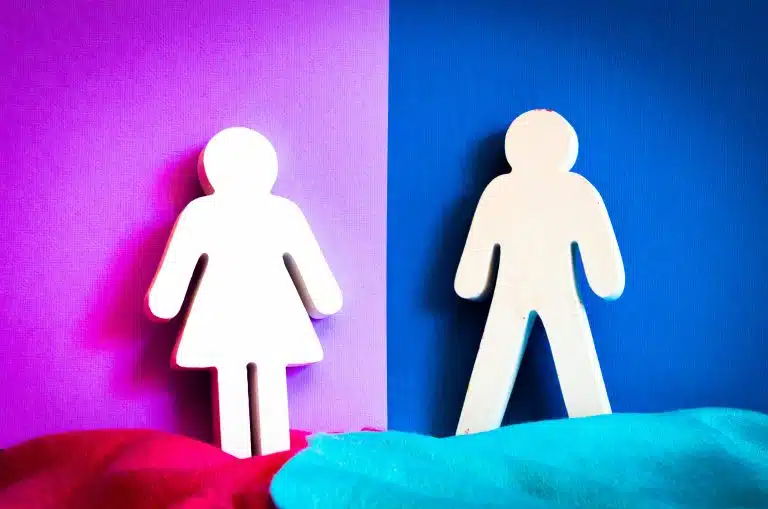Identità, solidarietà, sicurezza, società, reciprocità, inclusione/esclusione, vicinato, relazioni, reti, confidenza, fiducia, connessione, sussidiarietà, amministrazione condivisa, partecipazione e molti altri termini costituiscono i “chicchi” che moltiplicano, definiscono, confondono (persino!), il significato di questa parola significante.
Allo scopo di rendere utile questo breve scritto ci focalizzeremo molto sinteticamente sulle “tonalità” che il termine comunità assume nel DM 77/2022 e nella fondamentale declinazione toscana rappresentata dalla DGRT 1508/2022
Gli studi sul significato e sulle implicazioni metodologiche connesse al concetto di Comunità ricorrono in autori che, anche ad una comprensione non specialistica come quella di chi scrive, risultano di fondamentale rilevanza nell’orizzonte della sociologia, dell’antropologia e dell’economia: Ferdinand Tönnies, Henry J. Sumner Maine, Max Weber, Émile Durkheim (ricordando la sua teoria dei Patterns), Talcott Parsons Karl Polany (le relazioni di reciprocità), solo per citare alcuni “classici”.
E d’altra parte, non è difficile notare come anche nel panorama del dibattito teorico ed empirico che impegna le scienze sociali, i welfare studies e l’operatività dei servizi il termine comunità sembra assumere l’aspetto di un torrente carsico, che talvolta viene ricacciato, sottoposto a critica per la sua ambiguità, ma continuamente evocato come ponte, metafora di una necessità fondamentale anche in relazioni ai percorsi di identità e di fiducia che confluiscono nell’alveo della cosiddetta “resilienza di comunità”, concetto che assume persino declinazioni di sicurezza e tutela ambientale da parte dei cittadini e delle cittadine di un dato habitat.
Si può tuttavia far riferimento, pur in maniera estremamente sintetica, ad alcune recenti proposizioni espresse da Fabio Folgheraiter nel suo Manifesto del Metodo del Relational Social Work in due assiomi, così come lo stesso autore li definisce e articola il suo contributo scientifico, che concorrono a considerare il termine comunità in una prospettiva di utilizzo efficace nello sviluppo di sistemi territoriali di welfare: Assioma E4 che reca il titolo “l’aiuto è sempre relazionale”, e Assioma PM 1 “Al welfare di ogni territorio contribuisce la sua intera società”
Se torniamo al nostro “campo di elezione” costituito dal dm 77/2022 e dalla dgrt. 1508/2022 e proviamo a ripercorrere le declinazioni del termine comunità contenute nei testi, se ne evidenziano alcuni usi peculiari e di rilevante interesse:
- si parla di comunità locali, ovvero si carica il concetto di una attenzione specifica alle relative peculiarità territoriali e anche ad uno spazio confinato, definito con una attenzione, per quanto solo indicata, alle identità culturali e storiche delle comunità locali stesse.
- la comunità viene identificata come una sorta di organismo di cui è necessario curare il benessere, osservare le esigenze, coglierne le risorse, insomma un oggetto di salute
- si riconosce un protagonismo alle comunità locali, sempre intese come corpi unitari, e si indica la necessità di operare azioni di “empowerment delle risorse umane, professionali, della famiglia e delle comunità”; si individua come elemento di innovazione della case di comunità il fatto che “la comunità degli assistiti non è solo destinataria di servizi ma anche parte attiva nella valorizzazione delle competenze presenti all’interno della comunità stessa”; si fa riferimento anche alla partecipazione della comunità locale, delle associazioni di cittadini, dei pazienti e dei caregiver.
- si indica programmaticamente come “Rispetto a un quadro così alto e sfidante, le azioni a supporto dei servizi diventano fondamentali quanto l’erogazione delle singole prestazioni. Costruire partenariati solidi e significativi tra tutti gli attori, sfruttare le opportunità offerte dall’insieme molto ampio dei fondi a disposizione, promuovere la partecipazione e l’incontro con le comunità locali”.
Viene da chiedersi se questa rappresentazione della comunità corrisponda al complesso delle relazioni sociali in un dato territorio, ma, al netto di questa complessa domanda, siamo spinti a cercare di sollevare delle riflessioni rispetto ai modelli di intervento che possano dare luogo a funzionamenti concreti e attivabili di sviluppo di comunità.
Una prima prospettiva si può ricavare dal binomio cura/prossimità che a più riprese ritorna nel testo nelle brevi citazioni qui di seguito riportate:
la Casa di Comunità è il luogo fisico e di facile individuazione al quale i cittadini possono accedere per bisogni di assistenza sanitaria, sociosanitaria a valenza sanitaria ed è il modello organizzativo per l’assistenza di prossimità per la popolazione di riferimento
Il termine “prossimità” in sanità si riferisce alla capacità di fornire servizi sanitari e assistenza il più vicino possibile al luogo di residenza del paziente. Questo concetto è fondamentale per garantire un accesso equo e tempestivo alle cure, riducendo la necessità di spostamenti e migliorando la qualità della vita dei pazienti, soprattutto quelli con malattie croniche o disabilità.
E’ tuttavia la descrizione del ruolo dell’Infermiere di Famiglia e Comunità che indica drive operativi in termini di spazio di comunità: “nel rispetto delle sue caratteristiche peculiari quali la territorializzazione, la trasversalità delle competenze, la proattività dell’intervento e la gestione proattiva della salute attraverso attività di promozione della salute, prevenzione e gestione partecipativa dei processi di salute individuali, familiari e di comunità, la facilitazione e l’equità di accesso ai servizi”.
Si richiama qui il modello della community care le cui caratteristiche potremmo declinare secondo i seguenti item:
- Assistenza territoriale: i servizi vengono erogati vicino alla persona, favorendo la continuità delle cure.
- Integrazione sociosanitaria: unisce servizi sanitari e sociali per una presa in carico più sia la efficace.
- Ruolo delle reti sociali: la comunità diventa un attore attivo nel supporto alle persone fragili.
- Cure formali e informali: include sia servizi professionali che il supporto spontaneo.
La citata dgrt 1508/2022 dichiara che i principi di riferimento saranno: la comunità, l’integrazione e l’innovazione: vale aggiungere, In particolare sulla direzione dell’innovazione, come nel documento guida “Empowering people driving change – Social Innovation in European Union – Bureau of European Social Advisors, (Bepa) – European Communities 2011, l’innovazione stessa è così descritta “Le innovazioni sociali sono innovazioni che sono sociali sia nei loro fini che nei loro mezzi. In particolare, definiamo le innovazioni sociali come nuove idee (prodotti, servizi e modelli) che soddisfano simultaneamente i bisogni sociali (in modo più efficace rispetto alle alternative) e creano nuove relazioni sociali o collaborazioni. Sono innovazioni che non solo giovano alla società, ma aumentano anche la sua capacità di agire.”
Riteniamo fallace l’approccio che tende a considerare la comunità/le comunità locali come un prodotto naturale, e non ci sembra condivisibile il pensiero che la prossimità geografica ai servizi e dei servizi e la convivenza negli stessi spazi, specialmente in habitat dispersi, generi una comunità intesa come insieme coeso e dotato di strumenti di azione e scopi condivisi e orientate al perseguimento di beni comuni e di solidarietà: assistiamo peraltro anche a quei fenomeni di chiusura identitaria che qualche autore definisce come “comunità di rancore”.
E tuttavia le molte esperienze fatte nel campo dell’innovazione sociale e dello sviluppo di comunità ci dicono che si può agire agendo su diversi piani:
- portare i servizi vicino ai cittadini (localizzare);
- favorire la costruzione di comunità (socializzare);
- estendere la rete degli attori coinvolti (includere);
- coinvolgere attori inizialmente non previsti (diversificare);
Tutti e cinque questi piani d’azione sono importanti, ma quello cruciale, quello senza il quale neanche gli altri possono avere successo, è, secondo l’opinione di chi scrive, il secondo: costruire comunità. Questa azione richiede un forte investimento in termini di fiducia reciproca e un lavoro sulle reti, sia in termini di riconoscimento e consolidamento che di costruzione e promozione.
La necessità di costruzione di un welfare di comunità solleva dunque questioni complesse e di portata bel più ampia di quanto si sia riuscito a dire: volgiamo qui infine proporne una definizione ripresa da uno studio di Donati, e Maspero in una pubblicazione del 2021 dedicato appunto alla rigenerazione delle comunità dopo il covid. “Il welfare di comunità è l’insieme delle azioni (Policy e interventi di rete) che istituzioni pubbliche, imprese, società civile organizzata e Famiglie realizzano insieme in rete per creare un tessuto sociale che è comunitario in quanto l’appartenere ad esse è fonte di un benessere condiviso da singole persone e famiglie: la comunità è una We-realtionality. Ci riconnettiamo qui a quanto sopra premesso rispetto agli studi di Folgheraiter per sottolineare come la comunità non possa essere oggetto di affermazioni fideistiche quasi fosse un presupposto dato, ma neppure svalutata come mera proiezione volontaristica sul tessuto delle concrete relazioni sociali.”
di Andrea De Conno – Federsanità ANCI Toscana
[Foto di Maja Petric su Unsplash]