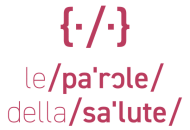Il temine burnout nasce dall’unione delle parole inglesi “burn” (bruciare) e “out” (fuori/completamente). L’accostamento dei due termini veniva usato in origine per descrivere qualcosa che smette di funzionare perché il suo combustibile si è esaurito; l’esempio più semplice è una candela che, una volta consumata la cera, si spegne. Apparso per la prima volta nel 1961 in un racconto di Graham Greene, in cui un famoso architetto disilluso e insoddisfatto abbandona il suo lavoro e la sua vita per fuggire in Congo, il termine viene introdotto in ambito psicologico negli anni ’70 dal Dott. Freudenberger. La sua ricerca si concentrò sulle condizioni di esaurimento di professionisti sanitari come infermieri, medici e assistenti sociali, nei quali rilevò un insieme di sentimenti e condizioni causati dallo stress lavorativo e, in particolare, dallo scoramento tra la dedizione, i risultati attesi e la realtà. Partendo da questi primi risultati, la dott.ssa Maslach coniò quella che oggi conosciamo come la sindrome da burnout lavorativo, per la cui identificazione elaborò un primo test già negli anni ’80. Da questi primi passi si è giunti a capire che il burnout non è semplice stanchezza, ma una condizione psicofisica complessa con radici profonde nell’ambiente e nelle dinamiche lavorative. Per tale ragione è riconosciuto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e inserito nell’International Classification of Diseases (ICD-11) come una sindrome, pur non essendo ancora classificato tra i disturbi psichici nel Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5).
Per una categoria fortemente a rischio – gli/le assistenti sociali – in Italia è stato introdotto un LEPS (Livello Essenziale di Prestazioni Sociali) che prevede la supervisione professionale, un intervento volto a prevenire il burnout e a sostenere il benessere psicologico degli operatori e dei servizi sociali.
Considerando che la sindrome da burn out si riferisce solo all’ambito lavorativo è essenziale osservare quali siano le aree del lavoro che, se gestite in modo inadeguato possono portare allo sviluppo della sindrome:
- Carico di Lavoro: un eccessivo carico, sia qualitativo che quantitativo, depriva gli individui delle capacità di soddisfare le richieste, lasciando poche opportunità per riposare e recuperare l’equilibrio.
- Controllo: una marcata mancanza di controllo e di autonomia sul proprio lavoro è direttamente legata allo sviluppo del burnout. Al contrario, la capacità di influenzare le decisioni e di accedere alle risorse necessarie promuove il coinvolgimento.
- Ricompensa: un riconoscimento insufficiente, economico o sociale, svaluta il lavoro e il lavoratore, alimentando sentimenti di inefficacia.
- Comunità: relazioni lavorative caratterizzate da mancanza di supporto, sfiducia e conflitti irrisolti aumentano il rischio di cinismo e mancata realizzazione.
- Equità: la percezione di ingiustizia nei processi decisionali sul luogo di lavoro genera cinismo, rabbia e ostilità.
- Valori: un divario tra i valori individuali e quelli organizzativi porta a una perdita di autorealizzazione e a un senso di alienazione dal proprio lavoro.
Considerando quindi queste aree e gli studi effettuati sul burn out si arriva a identificarne tre elementi principali:
- Sensazione di esaurimento: si riferisce alla percezione di essere sovraccarichi e svuotati delle proprie risorse emotive e fisiche, senza possibilità di ricaricarsi. Si avverte la sensazione di non essere in grado di affrontare una nuova giornata o una nuova sfida. Questa componente rappresenta la dimensione individuale di base del burnout.
- Aumento del distacco mentale e forte cinismo: si manifesta con una risposta negativa, ostile o eccessivamente distaccata verso il lavoro, che spesso include una perdita di idealismo. Nasce come meccanismo di autodifesa dall’esaurimento, ma rischia di degenerare da semplice distacco a mancanza di empatia e umanità. Questa componente rappresenta la dimensione interpersonale del burnout.
- Senso di inefficacia e mancata realizzazione: si sperimenta un calo della propria competenza percepita e della produttività. Cresce un senso di inadeguatezza riguardo alla capacità di svolgere bene il lavoro, che può sfociare in un verdetto autoimposto di fallimento e in una perdita di soddisfazione. Questa componente rappresenta la dimensione di autovalutazione del burnout.
Per distinguere il vero burnout dal semplice stress lavorativo, è essenziale che siano presenti contemporaneamente tutte e tre le dimensioni. Non si tratta di burnout se lo stress è temporaneo e i suoi effetti regrediscono con il riposo; in quel caso, si tratta al massimo di un affaticamento passeggero che ogni lavoratore, sebbene affronti periodi di pressione, può normalmente gestire con adeguate strategie e pause. Il burnout emerge quando le strategie di coping individuali non sono più sufficienti, lo stress diventa cronico e le sue conseguenze si riversano dal lavoro alla vita privata. Analogamente, il burnout non va confuso con la sindrome da fatica cronica, che può investire l’intera vita dell’individuo e non solo la sfera lavorativa, né con altri disturbi legati allo stress come il disturbo post-traumatico da stress (PTSD), che a differenza del burnout è classificato nel DSM-5.
Come si può intuire dalle aree considerate e dalle caratteristiche del burnout, questa sindrome non si manifesta improvvisamente, ma presenta sintomi che compaiono in maniera graduale, in un processo descrivibile in quattro fasi:
- Entusiasmo: il lavoratore è molto attivo e dedito al lavoro anche a costo di sacrificare momenti personali, in un percorso che ricalca una dipendenza. Si prefigge risultati, cambiamenti e obiettivi altissimi, spesso irrealistici e molto sfidanti, che vuole raggiungere per ottenere le relative ricompense in tempi molto brevi.
- Stagnazione: la persona si accorge presto che gli sforzi non danno i risultati attesi e che il lavoro inizia a non soddisfarla pienamente. L’entusiasmo cala drasticamente e subentra la delusione, accompagnata da un atteggiamento passivo e rinunciatario.
- Frustrazione: il lavoratore mette in discussione l’efficacia del proprio operato e il valore dell’organizzazione, sentendosi impotente, ostacolato e irritato.
- Apatia: per proteggersi dalla frustrazione e dalla delusione, il lavoratore sviluppa un atteggiamento di distacco, cinismo e indifferenza. Il lavoro perde ogni significato emotivo, così come le relazioni con colleghi e clienti. Il forte senso di apatia sviluppato rischia di dilagare, raggiungendo anche la sfera privata.
La persona giunge quindi a una condizione che non ha una durata precisa e, se non vengono messe in atto strategie di contenimento o trattamenti, il burnout può durare anche mesi, fino a protrarsi per periodi più lunghi.
Per superare il burnout è necessario un intervento combinato a livello individuale e organizzativo poiché se le strategie individuali sono utili per gestire i sintomi, la vera soluzione risiede nel modificare le condizioni lavorative che hanno generato la sindrome.
Il primo passo fondamentale è creare una distanza psicologica e fisica dal lavoro creando un distacco psicologico; in altri termini “smettere di pensare al lavoro durante il tempo libero” vivendo un effettivo momento di pausa. Durante questa fase, è essenziale adottare strategie individuali per la gestione dello stress come ad esempio interventi basati sulla mindfulness che si sono dimostrati efficaci nel ridurre significativamente i livelli di esaurimento emotivo. Qualora le strategie individuali non bastino il supporto psicologico professionale può diventare indispensabile. La terapia cognitivo-comportamentale (CBT) è uno degli approcci più validati per aiutare la persona a modificare schemi di pensiero disfunzionali (come il perfezionismo) e a sviluppare strategie di coping più efficaci per gestire le richieste lavorative in modo più sano.
Tuttavia, questi interventi individuali rischiano di non essere sufficienti nel momento in cui non si agisce sulla causa del problema: l’ambiente di lavoro. Le strategie focalizzate sull’organizzazione (come la riprogettazione del lavoro, la riduzione del carico, l’aumento dell’autonomia e il miglioramento del supporto sociale) sono le più efficaci per ridurre il burnout in modo duraturo in quanto intervengono sui sei fattori di rischio identificati in precedenza.
In conclusione il percorso di guarigione inizia certamente con il recupero delle energie individuali e l’adozione di utili strategie di distacco, ma si completa solo quando vengono affrontate e risolte le criticità organizzative che hanno innescato la sindrome.
Di Alessio Arces – Federsanità ANCI Toscana
[Foto di Nataliya Vaitkevich su Pexels]