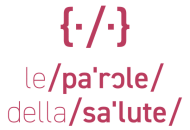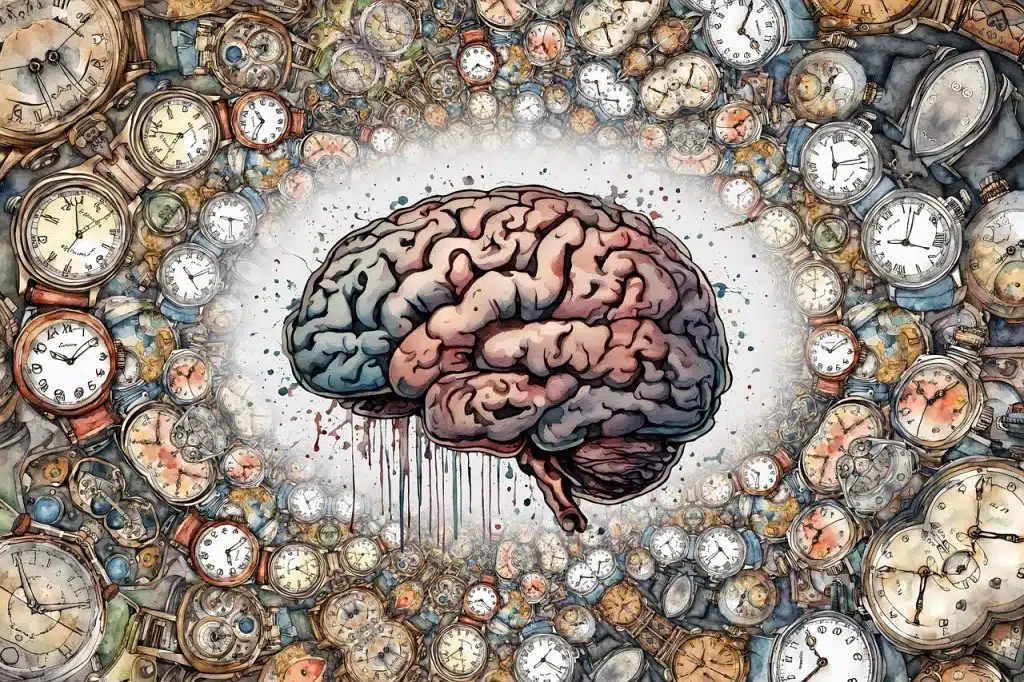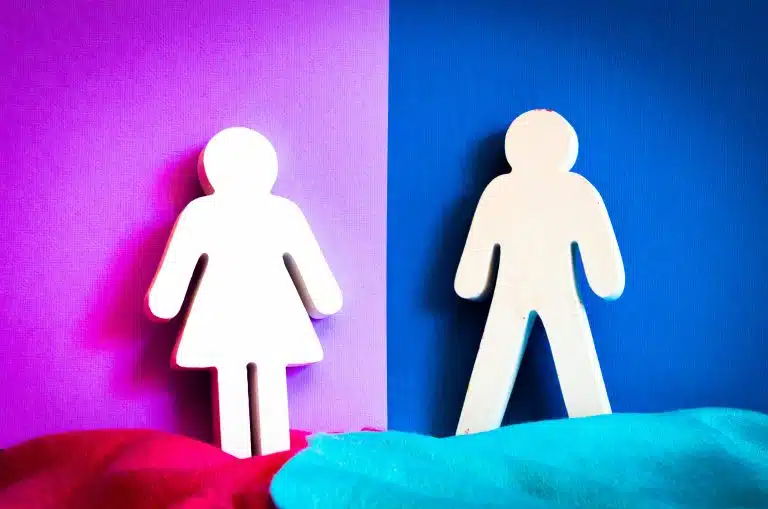Che cos’è la demenza
La demenza non è solo una malattia, ma un’esperienza complessa che coinvolge la persona malata, la sua famiglia, i medici, i caregiver e la società nel suo insieme. Si tratta di un percorso che richiede competenze multidisciplinari e relazioni di cura fondate sull’ascolto, il supporto e la condivisione. Le strategie terapeutiche a disposizione per le demenze sono di tipo farmacologico, psicosociale e di gestione integrata per la continuità assistenziale. Rispetto alle terapie farmacologiche, sebbene ad oggi siano in corso numerosi progetti di ricerca per individuare terapie efficaci nella cura della demenza, purtroppo gli interventi disponibili non sono ancora risolutivi. Tuttavia, la ricerca farmacologica in continua evoluzione, lascia ben sperare per un prossimo futuro in cui si prevedono terapie in grado di contrastare l’evoluzione della malattia con un miglioramento della qualità della vita del malato e della famiglia, oltre che con un importante risparmio della spesa sanitaria. Aspetto fondamentale per l’accesso alle nuove terapie sarà la diagnosi precoce, per questo la rete dei servizi a livello territoriale dovrà necessariamente adeguarsi e innovarsi per garantire risposte adeguate ai bisogni di cura.
Definizione e diffusione
La demenza è una condizione clinica cronico-degenerativa (ma anche vascolare, metabolica o infiammatoria) caratterizzata da un progressivo deterioramento di funzioni cognitive come memoria, linguaggio e ragionamento, fino alla perdita dell’autonomia.
- Colpisce circa l’1-2% degli over 65, e il 30% degli over 85.
- Nel mondo, nel 2010 erano colpite 35 milioni di persone: si stima che il numero triplicherà entro il 2050.
- Anche se è più frequente in età avanzata, può comparire già tra i 45 e i 64 anni (demenza a esordio precoce).
In Italia, il numero totale dei pazienti con demenza è stimato in oltre un milione (di cui circa 600.000 con demenza di Alzheimer) e circa 3 milioni sono le persone direttamente o indirettamente coinvolte nell’assistenza dei loro cari. Le conseguenze anche sul piano economico ed organizzativo sono facilmente immaginabili.
Cause e fattori di rischio
L’età è il principale fattore di rischio non modificabile. Tuttavia, una commissione scientifica internazionale ha identificato 12 fattori di rischio modificabili, tra cui:
- Basso livello di istruzione
- Ipertensione
- Perdita dell’udito
- Fumo, obesità, inattività fisica
- Diabete, depressione, isolamento sociale
- Traumi cranici e inquinamento atmosferico
Modificare questi fattori può prevenire fino al 40% dei casi di demenza.
Nel 2005, l’American Alzheimer Association ha pubblicato un elenco dei primi sintomi della Demenza, soprattutto perchè possano essere colti da chi vive con il malato, con lo scopo di avere una diagnosi precoce:
- andare in confusione ed avere dei vuoti di memoria,
- non riuscire più a fare le cose di tutti i giorni,
- faticare a trovare le parole giuste,
- dare l’impressione di avere perso il senso dell’orientamento,
- indossare più abiti, uno sopra all’altro, come se non si sapesse vestire,
- avere problemi con il conteggio dei soldi,
- riporre gli oggetti in posti inconsueti,
- avere sbalzi d’umore senza motivo,
- cambiare carattere,
- avere meno interessi e meno spirito d’iniziativa
Quando sono visibili tre o quattro di questi comportamenti, è bene rivolgersi al proprio medico.
Prevenzione: si può fare molto
Agire sulla prevenzione è oggi una priorità della sanità pubblica. Fin dalla giovinezza (ad esempio migliorando il livello di istruzione) fino alla terza età (contrastando l’isolamento, promuovendo l’attività fisica e mentale) è possibile ridurre significativamente il rischio di sviluppare demenza.
Aspetti etici
Con il declino cognitivo, la persona può perdere la capacità decisionale. Tuttavia, anche nelle fasi avanzate della malattia, può conservare emozioni, preferenze e relazioni significative.
È quindi importante valutare attentamente la capacità di intendere e di volere, per tutelare i diritti del paziente senza comprometterne l’autonomia.
Come si diagnostica la demenza
La diagnosi si basa su:
- Colloqui clinici e test neuropsicologici
- Esami strumentali come TAC e risonanza magnetica
- Esami del sangue e delle urine per escludere altre cause
- In casi selezionati, anche esame del liquido cerebrospinale
Dopo la diagnosi, è essenziale stabilire il tipo di demenza. Le principali forme sono:
- Alzheimer (più del 60% dei casi)
- Demenza vascolare
- Demenza a Corpi di Lewy
- Demenza frontotemporale
Una società più inclusiva e consapevole
Negli ultimi anni sono nate molte iniziative e associazioni che promuovono un nuovo approccio alla demenza, basato su cura, relazione, inclusione sociale e consapevolezza. Accanto alla medicina tradizionale, oggi si affiancano discipline come l’arteterapia, la medicina narrativa e il supporto ai caregiver, per migliorare la qualità di vita di tutti gli attori coinvolti.
Se la persona che riceve una diagnosi di Demenza non ha particolari fragilità, è bene facilitargli la consapevolezza del “suo” problema, evitando un eccesso di protezione. La persona interessata può avere paura e preoccupazioni, pensando a quello che le potrà capitare. L’affetto, la comprensione, la rassicurazione possono rispondere ai suoi bisogni emotivi molto di più del “far finta di niente”. Cosa non dire e non fare? La non accettazione della malattia ci può portare a pretendere dal malato cose che non è più in grado di fare, rimproverandolo quando sbaglia, con l’effetto di causargli ansia e frustrazione.
La “relazione di cura”
Anche se l’Alzheimer e le altre forme di Demenza sono malattie degenerative, con un andamento progressivo, che ancora non sappiamo come arrestare, l’evidenza scientifica e l’esperienza dei luoghi di cura mostrano che, se l’ambiente di vita del malato è adeguato ai suoi bisogni, ci può essere un effetto di contrasto alla progressione della malattia, in termini di contenimento dei sintomi, mantenimento delle funzioni e qualità della vita. E’ importante che l’ambiente sia rassicurante e faciliti l’orientamento e che al malato siano proposte attività che consentano un esercizio quotidiano delle funzioni fisiche e cognitive. Come avviene nell’invecchiamento fisiologico, l’esercizio delle funzioni ne garantisce il mantenimento. Oltre a questa “relazione di cura”, basata sulle competenze, ha un effetto benefico la relazione affettiva, di cui sono portatori naturali i familiari e gli amici più cari.
La rete di servizi territoriali a supporto dei malati e delle famiglie
La rete dei servizi per la Demenza è molto diversa da regione a regione. Il Centro Diurno Alzheimer è un luogo di eccellenza per la cura del malato, consentendo anche un alleggerimento del carico assistenziale della famiglia. Il sistema sanitario, inoltre, prevede ambulatori di Medicina Specialistica (Neurologia, Geriatria o Psichiatria), chiamati CDCD (Centri per i Disturbi Cognitivi e la Demenza) con competenze per diagnosi e terapia. Negli ultimi anni poi diverse regioni, Toscana in primis, hanno avviato varie iniziative e interventi a sostegno della domiciliarità dei malati. Come il “Caffè Alzheimer” e l'”Atelier Alzheimer”, pensati come servizi di “prossimità” alle famiglie. Questi servizi offrono a malati e famiglie occasioni di apertura sociale e riabilitazione, molto importanti per sostenere il lavoro di cura svolto dalle famiglie stesse.
Di Davide Lacangellera – ANCI Toscana e Psicologo Psicoterapeuta